Il cuore buddista del counseling
Il cuore buddista del counseling (cap. 6.2, “Manuale di Formazione IN Counseling”)
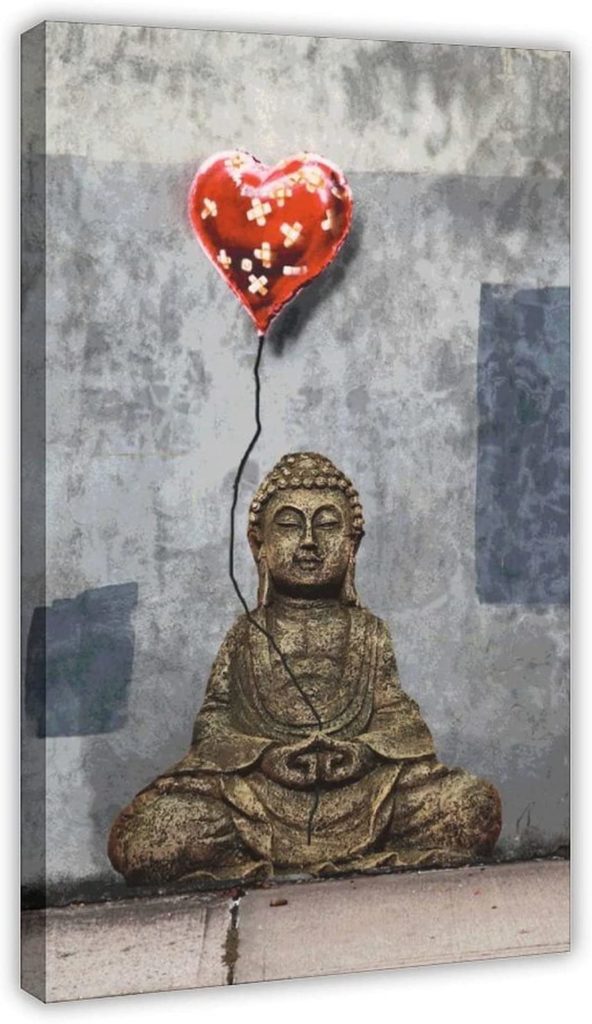
Da un punto di vista teorico-culturale, il counseling è un’attività che affonda le proprie radici nella Maieutica Socratica, germoglia nella cultura filosofica della Fenomenologia e dell’Esistenzialismo, si sviluppa con la Psicologia Umanistica.
Il Buddismo è una filosofia di vita che della Maieutica Socratica, della Fenomenologia, dell’Esistenzialismo e della Psicologia Umanistica, anticipa le intuizioni e le visioni più importanti (vedi i capitoli seguenti, 6.3 e 6.4).
Per questa ragione, quella del buddismo è una “Storia” e una Filosofia la cui conoscenza è di grande aiuto per chi vuole imparare a fare counseling e poi farlo.
Per questa ragione, in questo Manuale, non poteva mancare un capitolo sul buddismo.
Procederemo, quindi, con una prima presentazione dei capisaldi del buddismo e, successivamente, presenteremo le derivazioni culturali, “spirituali” e pratiche che il counseling, dello stesso, fa proprie.
Le conoscenze sul buddismo che qui sono proposte, in particolare, sono tratte da quattro testi, scelti tra la miriade di opere sul buddismo, per la loro chiarezza e autorevolezza:
- Mark Epstein, “Pensieri senza un pensatore”, Ubaldini Editore, Roma, 1996
- B. Alan, “I quattro incommensurabili”, Ubaldini Editore, Roma, 2000
- Walpola Rahula, “L’insegnamento del Buddha”, Adelphi, 2019
- Stefano Bettera, “Fai la cosa giusta”, Morellini editore, 2018
Ma l’ideazione di tutto ciò che in queste pagine è stato scritto mi è stata possibile grazie all’aver esercitato direttamente, in prima persona, una piccola parte degli insegnamenti del Buddha, in particolare quelli relativi alla meditazione e alle sue molteplici possibilità di praticarla, apprese nel corso delle esperienze di Formazione IN Counseling, prima come allievo, poi come trainer.
La comprensione degli insegnamenti del Buddha è impossibile senza la pratica dei suoi insegnamenti.
Il Buddha è stato un maestro che insegnava cose pratiche, invitando a esercitarle, applicandole; perché solo l’esperienza che da questo sarebbe scaturita avrebbe portato i benefici attesi.
Così è per il counseling, che è esperienza pratica di una particolare relazione interpersonale, che, facendone esperienza, ci fa stare meglio.
Ecco anticipato il primo collegamento Buddismo-Counseling: entrambi hanno valore e producono i loro effetti perché sono un’esperienza pratica.
Gli altri collegamenti saranno analizzati nella parte finale di questo capitolo, intestata con il suo stesso titolo: “Il cuore buddista del counseling”.
Il Buddha visse nel VI secolo A.C. nel regno dei Sakya, India del Nord (odierno Nepal).
Si chiamava Siddharta, della famiglia reale dei Gautama, figlio del sovrano e principe.
All’età di 29 anni, abbandonò moglie e figlia, la famiglia e il palazzo reale e la sua vita sfarzosa per dedicarsi, asceticamente, alla ricerca della via che avrebbe condotto al superamento della sofferenza.
Il suo fu un duro e tormentato percorso d’introspezione critica e meditazione, durato 6 anni.
Fece esperienza di varie forme estreme (fame, sete e sofferenze auto inflitte) di ascetismo, per arrivare a comprendere che la conoscenza salvifica che stava cercando poteva avvenire sì attraverso forme di meditazione profonda, ma solo con un corpo sano e in buone condizioni; riprese così a vivere una “normale” vita da monaco e ad alimentarsi “normalmente”.
All’età di 35 anni, nel 530 A.C., dopo sette settimane di meditazione profonda, ininterrotta, in una notte di maggio, di luna piena, seduto a gambe incrociate, nella posizione del loto, sotto un albero di fico, a Bodh Gaya, Siddharta raggiunse l’illuminazione, il Nirvana, lo stato di comprensione assoluta delle cose della vita.
Adesso era il Buddha.
“Buddha” è il nome che nella cultura buddista è assegnato a chi raggiunge la condizione di illuminato e non certo, come erroneamente alcuni credono, il nome di un Dio.
Da lì a poco, superati i dubbi su cosa farsene di questa sua nuova condizione di “Risvegliato”, il Buddha si dedicò all’insegnamento di quanto aveva scoperto e appreso.
Gli insegnamenti buddisti, storicamente, hanno prodotto varie forme e declinazioni, dividendosi, in particolare, in due Scuole:
- Theravada (piccolo veicolo, scuola degli anziani), scuola ortodossa originaria; buddismo praticato in Sri Lanka, Birmania, Thailandia, Cambogia, Laos, India e Bangladesh.
- Mahayana (grande veicolo), si sviluppa in un secondo tempo ed è il buddismo praticato in Cina, Giappone, Tibet, Corea, Mongolia, ecc.
Pur differenziandosi in alcune credenze e pratiche, le due scuole concordano sugli insegnamenti fondamentali del Buddha, che sono:
- Le quattro nobili verità
- I cinque aggregati
- L’ottuplice sentiero
- Il karman
- La rinascita
- La genesi condizionata (paticca-samuppada)
- Il “non sé” (anatta)
- I fondamenti della consapevolezza (satipatthana)
Alla base dell’insegnamento del Buddha risiedono le sue “Quattro nobili verità”, pronunciate nel suo primo discorso da “illuminato” e, successivamente, trascritte e variamente spiegate in ogni “testo sacro” buddista.
LE 4 NOBILI VERITÀ del Buddha sono:
- Dukkha (nella vita c’è la sofferenza e c’è la felicità, c’è il bene e c’è il male)
- Samudaya (l’origine e le cause della sofferenza)
- Nirodha (la cessazione della sofferenza)
- Magga (il sentiero che conduce alla cessazione della sofferenza)
DUKKHA. LA PRIMA NOBILE VERITÀ.
Nella sua prima nobile verità il Buddha parla della sofferenza come una caratteristica ineludibile della vita.
Intendendo con ciò il fatto che sia impossibile vivere senza fare esperienza della sofferenza e non, come scioccamente viene proclamato, che la vita sia sofferenza.
Pur non essendo organismi naturali votati alla sofferenza, ma al piacere e alla felicità, noi esseri umani soffriamo in collegamento alle circostanze dolorose che accompagnano, ineludibilmente, il nostro vivere (la frustrazione, la malattia, l’impotenza, gli incidenti, la guerra, l’invecchiamento, ecc. ecc.).
Noi umani, come ogni essere vivente, rifuggiamo spontaneamente il dolore e ricerchiamo, sempre spontaneamente, il benessere.
“Dukkha” è un significante dallo spettro semantico amplissimo, che comprende “tutto ciò cui possiamo rispondere con sofferenza”, quindi, paradossalmente, anche la felicità, quando la perdiamo, quando non riusciamo a ottenerla o abbiamo paura di non ottenerla; “dukkha” è, così, il nascere, il lavorare e l’invecchiare, il non ottenere ciò che vogliamo, l’impermanenza, l’imperfezione, la vacuità, l’insostanzialità di tutto ciò che riguarda la vita e noi stessi.
Si potrebbe dire che “dukkha” comprende la vita intera, il piacere e il dispiacere, la felicità e la sofferenza.
Con “dukkha” il Buddha declama la sua prima nobile verità: “non si può vivere senza soffrire”, ma questo non vuol dire che si debba vivere soffrendo, perché nella vita c’è anche “sukha”: la tranquillità, la pace, il piacere e la felicità; imparando ad accogliere e ad accettare “dukkha” (tutto ciò cui rispondiamo con sofferenza), lo stesso “dukkha” può essere usato come funzione che ci spinge a raggiungere “sukha” (il piacere, la pace, la tranquillità, la felicità), quando la stessa è persa o la stiamo perdendo.
Con le successive tre nobili verità, il Buddha espone la via che porta al superamento di “dukkha”; ma è di estrema importanza comprendere bene questa Prima Nobile Verità, perché, come dice il Buddha: “Chi vede il dukkha, ne vede il sorgere e la cessazione e vede la via che conduce alla cessazione della sofferenza”.
Per aiutare la comprensione di dukkha, il Buddha spiega il funzionamento della vita come funzione di sue 5 particolari strutture, che chiama i “5 aggregati”.
- PRIMO AGGREGATO: LA MATERIA.
In questo primo aggregato il Buddha include tutto ciò che può essere percepito (visto, udito, odorato, gustato, toccato) e i relativi organi che rendono possibili tali percezioni (occhio, orecchio, naso, lingua e corpo), nonché i 4 elementi della solidità, della fluidità, del calore e del movimento.
- SECONDO AGGREGATO: LE SENSAZIONI.
Innanzitutto, pensiamo alle sensazioni come agli effetti emotivi, fisici e mentali, che l’azione dei sensi ci procurano; cioè quello che ci accade quando vediamo, sentiamo, odoriamo, gustiamo, tocchiamo qualcosa e “lavoriamo” con la mente.
Sì, nell’aggregato delle sensazioni il Buddha inscrive anche gli effetti delle nostre attività mentali.
Nel buddismo i sensi sono 6, perché anche la mente è considerato un senso, al pari degli altri cinque (vista, udito, olfatto, gusto, tatto).
Mentre questi percepiscono il mondo materiale, la mente percepisce il mondo delle idee, della logica, dell’intuizione, della memoria e di ogni forma di pensiero (giudizio immaginazione, interpretazione, classificazione, associazione, ecc. ecc.)
Esperiamo diverse parti del mondo attraverso i diversi sensi fisici, la cui azione, variamente interagente, è sintetizzata dalla mente in specifiche concezioni.
Le idee e i pensieri che ci facciamo del mondo e della vita sono prodotti e condizionati dai nostri sensi, attraverso le esperienze che del mondo e della vita facciamo.
I sensi sono facoltà e funzioni percettive, tra queste rientrano quelle della mente.
- TERZO AGGREGATO: LE PERCEZIONI.
Le percezioni sono il frutto del contatto tra i nostri 6 sensi e gli oggetti (materiali e immateriali) che questi contattano (visione ripresa dalla Gestalt e così riformulata: “per una percezione, ci vuole un percipiente e ci vuole qualcosa da percepire”). È per il tramite delle percezioni che riconosciamo gli oggetti, fisici e mentali, con cui veniamo in contatto.
- QUARTO AGGREGATO: LE FORMAZIONI MENTALI.
Le formazioni mentali di cui parla il Buddha si avvicinano a quelli che noi chiamiamo, comunemente, atteggiamenti mentali e, in psicologia (Bowly), Modelli Operativi Interni (vedi capitolo sull’infanzia) o, più in generale, automatismi comportamentali variamente nevrotici.
Tali “formazioni mentali” sono strutture tendenzialmente fisse di emozioni, pensieri e azioni, che preordinano i nostri comportamenti, nel bene come nel male.
Alla base delle nostre formazioni mentali, e del loro opportuno cambiamento, Buddha individua la volizione: la volontà come pure atto, il volere che da funzione mentale diventa azione (anticipando così millenni di dispute filosofiche sulla volontà e, in ultimo, le intuizioni di Roberto Assagioli e della Psicosintesi).
La volontà, dunque, fa parte di questo quarto aggregato, come tutte le attività che dalla volontà discendono.
Lo stesso “karman” è compreso in questo gruppo, perché se il karman è quello che ci succede, quello che ci succede, per il Buddha, dipende dalla nostra volontà.
La nostra volontà è ciò che muove la nostra mente, le nostre parole e le nostre azioni.
A differenza delle sensazioni e delle percezioni, che non producono effetti karmici, la volontà, insieme ai pensieri, alle parole e ai comportamenti che ne derivano, producono il nostro karman (quello che nel nostro pensiero occidentale potrebbe essere visto come “destino”, con la differenza che il “Karman” è il destino che ciascuno si costruisce, anche se inconsapevolmente).
Le formazioni mentali dipendono dalla volontà.
Per il Buddha sono formazioni mentali l’attenzione, l’intenzione, la determinazione, la fiducia, la concentrazione, la saggezza, l’energia, il desiderio, l’odio e l’avversione, l’ignoranza, la vanità, l’idea del sé, ecc. ecc., insomma tutto ciò che, come ogni atteggiamento, preordina i nostri pensieri, i nostri sentimenti e, in fine, i nostri comportamenti.
- QUINTO AGGREGATO: LA COSCIENZA
Meglio sarebbe parlare di “stati di coscienza”, cioè quello che accade quando i sensi sono attivi nelle loro funzioni percettive, sensoriali e cognitive.
L’occhio che vede un oggetto dà il via alla coscienza visiva; l’orecchio che sente un suono dà il via alla coscienza uditiva e così via fino alla coscienza mentale, che vede la mente agire le sue declinazioni (giudicare, immaginare, riflettere, interpretare, stimolare emozioni e sentimenti vari, classificare, associare, ecc.) nei confronti di ciò con cui viene in contatto.
Come le sensazioni, le percezioni e le forme mentali, anche gli stati di coscienza sono di sei tipi, corrispondenti alle funzioni che ciascuno dei sei sensi attiva nei confronti del mondo e di ciò che nello stesso è possibile incontrare.
Parlare di stati di coscienza, piuttosto che di coscienza, aiuta a comprendere la visione del Buddha del “non sé”, opposta all’idea di una coscienza associabile a un “Sé”, una sorta di struttura animica, preesistente, che perdura nel tempo, magari travalicando la stessa esistenza individuale, un qualcosa che ciascun individuo è chiamato a scoprire, riconoscere, realizzare ed affermare.
Il Buddha insegna che la coscienza sorge a causa di condizioni, se non ci sono le condizioni la coscienza non nasce; inequivocabilmente afferma che la coscienza dipende dalla materia, dalla sensazione, dalla percezione e dalle formazioni mentali, e non può esistere indipendentemente da esse.
I modi in cui viviamo sono le condizioni che rendono possibili i nostri stati di coscienza, cioè le forme e i contenuti della coscienza, che non può che essere, quindi, contingente e impermanente.
Per il Buddha tutto quello che chiamiamo “essere”, “individuo” o “io”, è solo un’illusione cui diamo un nome convenzionale, un’etichetta data al modo in cui questi cinque aggregati finiscono col combinarsi.
Le combinazioni di questi cinque aggregati sono mutevoli e impermanenti.
Tutto ciò che è impermanente è “dukkha”, così è la vita umana.
L’insieme di questi cinque aggregati, al quale noi comunemente assegniamo il nome di “essere”, è “dukkha”.
Non c’è nessun altro “essere” o “io” dietro questi cinque aggregati, che esperisca “dukkha”.
Come dice il Buddha: “Esiste solo la sofferenza, ma non si trova colui che soffre. Le azioni esistono ed esistono i pensieri, ma l’autore non si trova”.
La vita santa, quella che porta alla pace e alla felicità, non dipende dal saper rispondere a quesiti quali:
- Esiste un vero Sé?
- L’universo è finito o no?
Nella sua dottrina, il Buddha dice:
“Qualsiasi opinione si abbia su questi problemi, esistono comunque la nascita, la vecchiaia, il decadimento, la malattia, la morte, la sofferenza, il lamento, il dolore, l’afflizione, l’angoscia, la cui cessazione è possibile in questa vita. Questo io ho spiegato. Ciò che non ho spiegato (se l’universo sia finito o no, se esiste il vero sé, ecc.) non l’ho spiegato perché è inutile per la nostra salvezza”.
SAMUDAYA. LA SECONDA NOBILE VERITÀ.
Conla sua seconda nobile verità, il Buddha ci parla dell’origine e delle cause della sofferenza. Lo fa ribadendo quanto espresso con la prima nobile verità e cioè che nella vita c’è il bene e c’è il male, la sofferenza e la felicità.
Il bene e il male, la sofferenza e la felicità sono legate da un rapporto d’interdipendenza: quando perdiamo il bene, stiamo male; stare male ci spinge a voler stare bene.
Stare bene, però, può spingerci a voler stare meglio, se diventiamo preda della sete di provare piacere e ci attacchiamo allo stesso desiderio.
La sofferenza non può avere un’unica causa, perché è resa possibile da un insieme di elementi e funzioni interagenti.
Ad esempio, come non considerare (e il Buddha lo fa) che la sofferenza dipenda dai nostri sensi, che ci rendono esseri sensibili, che sentono il dolore ed il piacere, la sofferenza e la gioia?
Ma il Buddha, con la sua seconda nobile verità ci dice che la causa prioritaria della sofferenza umana è il vivere il bisogno di benessere come sete/desiderio inesauribile di stare sempre e solo bene, è la continua ricerca del piacere crescente dei sensi, è l’attaccamento a questa sete/desiderio di benessere e piacere crescente, ed è, quindi, in prima e ultima istanza, l’indisponibilità a soffrire.
Sì, in prima e ultima istanza, la causa più importante del nostro soffrire è il nostro non essere disposti a soffrire, il rifiutare la sofferenza, il non aver chiaro il valore della sofferenza e, quindi, il non saperla accogliere, ascoltare ed accettare.
L’atteggiamento (“Formazione Mentale”) di rifiuto della sofferenza è il corrispettivo del nostro attaccamento al piacere e a tutto ciò che, di volta in volta, occasionalmente, potrebbe procurarcelo.
Mollare l’attaccamento è indispensabile per conoscere il valore della sofferenza e muoversi verso il suo superamento.
È necessario conoscere la sofferenza e le sue cause, per potersene liberare.
All’origine della sofferenza c’è la paura di soffrire, la corrispondente volontà di non soffrire e il desiderio del piacere dei sensi, ovvero il bisogno di stare bene, come pretesa del benessere assoluto, che non riusciamo ad ottenere.
Da qui la rinascita: la “sete/desiderio/brama” di benessere e piacere, continuo e assoluto, è alla base della “ri-esistenza”, del “ri-nascere”, del “ri-divenire”, ovvero del “karman” .
Per il Buddha il karman nulla ha a che fare con i concetti di giustizia divina, di punizione o di ricompensa morale.
Karman è la naturale legge/dinamica di corrispondenza tra ciò che vogliamo/facciamo e i relativi effetti.
Volizioni e comportamenti positivi producono effetti positivi (karman positivo).
Volizioni e comportamenti negativi producono effetti negativi (karman negativo).
Per questo la sofferenza è in dukkha e nella stessa dukkha c’è l’origine, il germe della sua cessazione (anticipiamo qui una riflessione sul rapporto Counseling-Buddismo: questo insegnamento del Buddha è ripreso da noi counselor con il nostro dare più valore ai mezzi, che i clienti utilizzano per raggiungere i loro scopi, che agli stessi scopi)
NIRODHA. LA TERZA NOBILE VERITÀ.
Nella sua terza nobile verità il Buddha ci parla della cessazione della sofferenza, affermando che esiste il nirvana: l’emancipazione, la liberazione, l’affrancamento dalla continuità di dukkha.
Il nirvana è l’estinzione della sete/desiderio, nei termini in cui questa è presentata nella seconda nobile verità.
Il nirvana è lo stato di comprensione della Verità Assoluta riguardante la Realtà della vita come della morte, delle cose del mondo come dello spirito; è uno stato di consapevolezza in cui la sofferenza è cessata.
Solo una mente illuminata può comprendere il nirvana: uno stato della mente che le nostre forme linguistiche non bastano a descrivere.
L’esperienza del nirvana è, in ultima istanza, la “Buddhità”: la condizione, lo stato del Buddha.
Il linguaggio è una creazione sociale, umana, che dà forma ai contenuti dell’esperienza umana, ne permette l’espressione, l’intelligibilità, la condivisione e la trasmissione.
Senza l’esperienza del nirvana è difficile parlare di nirvana.
Parlare di nirvana, senza poterne fare esperienza, è una pratica che non porta a una vera comprensione.
Il linguaggio promuove la crescita e lo sviluppo dell’esperienza umana, la facilita e la rende possibile, ma mai, da solo, riesce a creare un’esperienza.
Per fare un’esperienza è necessaria l’integrazione di diverse attività.
Il Buddha individua le attività che, debitamente praticate, possono portarci a fare esperienza diretta del nirvana.
Tali attività sono principalmente pratiche di meditazione, o attività volte alla meditazione.
Per avere forme linguistiche in grado di esprimere, comprensibilmente, i contenuti e il valore dell’esperienza del nirvana, bisognerebbe essere Buddha che vive in una comunità di Buddha!
Se parlare del nirvana non basta a comprenderlo, possiamo comprendere le attività che rendono possibile l’esperienza del nirvana.
Il Buddha ci parla del nirvana come accadimento che consegue alla dedizione nei confronti di specifiche pratiche di meditazione.
Di tali pratiche/attività è possibile e ha senso parlare, perché tutti ne possono fare e avere una qualche esperienza.
Questo è quanto il Buddha fa nella sua quarta nobile verità: non parla del nirvana, parla delle pratiche che portano al nirvana.
Ricapitolando, nella prima nobile verità il Buddha ci dice che esiste la sofferenza; nella seconda quali sono le sue origini; nella terza ci dice che la sofferenza può cessare; nella quarta ci indica la via per la cessazione della sofferenza: l’ottuplice sentiero.
Percorrere l’ottuplice sentiero porta all’illuminazione.
Una mente illuminata pone fine alla sofferenza.
MAGGA. LA QUARTA NOBILE VERITÀ.
Il sentiero che conduce all’eliminazione di dukkha, anche detto sentiero di mezzo (tra un’idea di felicità raggiungibile edonisticamente e il suo opposto ascetico).
Il Buddha scoprì per esperienza personale questo sentiero di mezzo e lo presentò come “la via che dà visione e conoscenza, la via che conduce alla quiete, alla penetrazione, all’illuminazione, al nirvana”.
È chiamato ottuplice sentiero perché è un cammino che si svolge su otto piani.
OTTUPLICE SENTIERO:
- Retta visione
- Retto pensiero
- Retta parola
- Retta azione
- Retta sussistenza
- Retto sforzo
- Retta consapevolezza
- Retta concentrazione
L’essenza degli insegnamenti del Buddha si trova nel Nobile ottuplice sentiero.
L’ottuplice sentiero si percorre praticando, contestualmente, gli otto “piani” che lo compongono.
Tali pratiche sviluppano e perfezionano tre qualità esistenziali fondamentali per la liberazione dalla sofferenza:
- La condotta morale
- La disciplina mentale
- La saggezza
La condotta morale è il nutrimento indispensabile dell’amore universale, compassionevole, nei confronti di tutti gli esseri viventi, proprio della filosofia buddista.
Per il buddismo, la perfezione umana è una condizione che si muove su due gambe: la compassione e la saggezza.
La compassione comprende l’amore, la carità, la bontà, la tolleranza e le emozioni nobili (la gioia, la tenerezza, la curiosità, ecc.), le emozioni del cuore.
La saggezza è la qualità della mente, le sue conoscenze e la sua intelligenza emotiva.
Compassione e saggezza vanno coltivate insieme e nella stessa misura, per vivere bene e fare del bene, evitando rischi quali vestire i panni dello “sciocco di buon cuore” o del “arido intellettuale”.
I piani 3, 4 e 5 dell’ottuplice sentiero (retta parola, retta azione e retta sussistenza) sono quelli della condotta morale.
LA RETTA PAROLA, per il Buddha, è quella di chi non mente, non calunnia, non provoca maldicenze, odio, inimicizia tra le persone. Retta parola è quella di chi non usa un linguaggio duro, maleducato, malizioso, ingiurioso. Retta parola è quella di chi non si dedica al pettegolezzo, al chiacchiericcio futile, vano, sciocco.
Retta parola è, quindi, dire la verità, usare forme linguistiche benevole, amichevoli, gentili, piacevoli, sensate e utili. Non si deve parlare con noncuranza, ma a proposito, rispettando tempi e luoghi e scegliendoli all’occorrenza. Retta parola è tacere quando non si ha nulla da dire, con rettitudine.
LA RETTA AZIONE, è quella che promuove una buona condotta morale, onorevole e pacifica. Non uccidere, distruggere, arrecare danno. Non rubare, non dedicarsi ad affari illeciti, non avere rapporti sessuali illegittimi, quelli che violano l’umanità altrui. Retta azione è dedicarsi a tutto ciò che promuove la propria e l’altrui vita pacifica e onorevole.
LA RETTA SUSSISTENZA, significa rifuggire ogni forma di attività lavorativa che possa nuocere agli altri, compresi gli animali: produzione e commercio d’armi o di sostanze tossiche e velenose; attività truffaldine; uccisione di animali, ecc.
Retta sussistenza è procurarsi da vivere in modo onorevole, senza far del male a nessuno.
Retta parola, retta azione, retta sussistenza, compongono la condotta morale delle persone.
Nel buddismo, la condotta morale è condizione indispensabile di ogni sviluppo e realizzazione spirituale.
La disciplina mentale comprende i piani 6, 7 e 8 dell’Ottuplice sentiero: retto sforzo, retta consapevolezza e retta concentrazione.
IL RETTO SFORZO è quanto possiamo fare per prevenire l’insorgere di idee malsane e stati mentali negativi; per sbarazzarcene quando siamo alle loro prese; per promuovere lo sviluppo di stati mentali sani e positivi.
LA RETTA CONSAPEVOLEZZA la presentiamo con le parole di Walpola Rahula, (op. cit.):
La Retta consapevolezza (o presenza mentale) consiste in un’attenzione vigile e consapevole:
- alle attività del corpo (kaja),
- alle sensazioni e alle emozioni (vedana),
- alle attività della mente (citta);
- alle idee, ai pensieri, ai concetti e alle cose (dhamma)..
La consapevolezza, nel buddismo è uno stato della mente.
Nel buddismo, i desideri e i sentimenti sono attività della mente e, in quanto tali, sono sue forme, come le sensazioni e le emozioni, le idee, i pensieri, i concetti e le cose.
Negli insegnamenti del Buddha, la consapevolezza è uno stato raggiungibile percorrendo la “via della meditazione”, intesa come pratica di sviluppo mentale.
Consapevolezza = Presenza mentale.
Lo stato di sviluppo mentale è ciò che possiamo chiamare stato di consapevolezza.
La meditazione che propone il Buddha è il mezzo (la via, appunto) per raggiungere uno stato di perfetta salute mentale, di equilibrio e di tranquillità.
Il termine “meditazione” non rende facile comprenderne il senso e la consistenza.
Spesso la meditazione è confusa con una qualche particolare attività della mente capace di sviluppare particolari “poteri” personali o di portare chi la pratica al pieno distacco dalle cose del mondo e dai propri tormenti interiori, uno stato personale di oblio generale e di pace universale.
Cosi non é.
“La meditazione buddista è, propriamente parlando, coltura mentale nel senso pieno della parola. Tende a ripulire la mente dalle impurità e dai suoi turbamenti (desideri sensuali, odio, malizia, indolenza, preoccupazioni,irrequietezza, dubbi scettici); tende a coltivare qualità come la concentrazione, l’attenzione, l’intelligenza, la volontà, l’energia, la facoltà analitica, la fiducia, la gioia, la calma, che conducono infine all’ottenimento della saggezza più alta, che vede le cose come realmente sono e che realizza la Verità ultima, il nirvana” (Walpola Rahula, op. cit.).
La forma di base, di meditazione buddista, è quella vipassana, “visione penetrativa” della natura delle cose.
La meditazione vipassana conduce alla completa liberazione della mente, alla realizzazione della Realtà ultima, al nirvana.
È un metodo analitico basato sull’attenzione, la vigilanza, l’osservazione.
Il discorso più importante che il Buddha abbia mai pronunciato sullo sviluppo mentale (meditazione) è intitolato Satipatthana-sutta, traducibile in “I Fondamenti della consapevolezza”.
Le forme di meditazione che in questo discorso sono proposte non sono distaccate dalla vita, dalle sue attività e dalle sue manifestazioni nell’esistenza umana, anzi a queste sono connesse, articolandosi su quattro piani di pratiche di meditazioni riguardanti:
- il corpo (kaja)
- i sentimenti e le sensazioni (vedana)
- la mente (citta)
- le questioni etiche e spirituali e, quindi, le idee, i pensieri, i concetti e le cose a tali questioni collegate (dhamma)
Dedicarsi all’insieme di queste pratiche di meditazione produce lo sviluppo mentale che sviluppa i nostri stati di consapevolezza.
- Il corpo (Kaja).
La forma più nota di meditazione riguardante il corpo è “la consapevolezza o presenza mentale dell’inspirazione e dell’espirazione”.
Si tratta di respirare prestando attenzione al respiro, concentrandosi sullo stesso, fino a diventarne pienamente consapevoli.
Questa pratica solitamente si appoggia su di una particolare postura del corpo (il fiore del loto, seduti a terra, a gambe incrociate e schiena diritta), ma la cosa non è da ritenersi obbligatoria (si può stare anche seduti su di una sedia)
Questa pratica di consapevolezza del respiro, debitamente esercitata, sviluppa la concentrazione indispensabile per il conseguimento di ogni tipo di comprensione e visione profonda della natura delle cose, inclusa la realizzazione del nirvana.
È una pratica salutare a tutto tondo. Esercitata quotidianamente, fa bene al corpo, allo spirito e alla mente.
Un’altra forma di meditazione molto importante è l’attenzione consapevole su tutto ciò che facciamo, fisicamente, mentalmente, verbalmente, dall’alzarsi dal letto a tutto ciò che segue (ogni singolo gesto, dall’allungare il braccio per prendere qualcosa al sedersi su una sedia, ad esempio), giorno dopo giorno.
Questo ci porta a vivere il tempo presente e a dargli valore, condizione esistenziale fondamentale per vivere e stare bene.
Nel suo discorso sui fondamenti della consapevolezza, il Buddha dice che la consapevolezza o presenza mentale riguardo alle nostre azioni significa vivere nel momento presente, vivere in ciò che si fa. In tale forma di meditazione non si deve fare niente di particolare, solo prestare attenzione ed essere consapevoli di ciò che si sta facendo.
- I sentimenti e le sensazioni (vedana).
Meditare sui propri sentimenti e sulle proprie sensazioni vuol dire prestare loro attenzione, accorgersi di loro, osservandone la nascita e gli sviluppi. Vuol dire orientare tutte le nostre facoltà sensoriali verso la loro percezione e con le nostre facoltà mentali analizzarne i contenuti e le dinamiche di insorgenza, sviluppo, cessazione.
È quello che facciamo noi counselor quando ci mettiamo in ascolto!
Ma nel buddismo questo avviene con un atteggiamento mentale diverso, quello di guardare alle sensazioni e ai sentimenti provati non come propri, ma oggettivamente, dimenticando la falsa idea dell’ “io”, guardando alle proprie sensazioni e ai propri sentimenti come sensazioni e sentimenti dotati di vita propria.
- La mente (citta).
Meditare sulla mente vuol dire osservare, guardare, esaminare i suoi stati, cioè ciò che accade in noi (come nasce, come si sviluppa, come cessa) e ciò che lo procura; senza giudicarlo o assumere nei suoi confronti alcuna posizione critica.
Per il buddismo sono stati della mente le nostre emozioni, i nostri sentimenti, le nostre passioni, i nostri pensieri e i nostri giudizi, le nostre idee e le nostre immaginazioni.
Praticare questa forma di meditazione ci porta a vedere le cose per quello che sono e a riconoscerne la natura.
- Le questioni etiche e spirituali, quindi le idee, i pensieri, i concetti e le cose a queste collegate (dhamma)
I nostri studi, le nostre riflessioni, le conversazioni e i confronti sui temi della vita e dell’esistenza, delle cose e delle persone, delle forze naturali e soprannaturali, sono forme di meditazione.
In particolare il buddismo invita a meditare sui “Cinque aggregati” (già presentati), sui “Cinque impedimenti”, sui “Sette fattori dell’illuminazione” e sui “Quattro (stati) Incommensurabili (dell’esistenza)”.
I cinque impedimenti:
- I desideri che distraggono dallo stare sulla retta via dell’ottuplice sentiero (le attrazioni “goderecce” dei sensi, dal sesso al cibo, a ogni piacere che i sensi e le attività mentali possono procurarci)
- La malizia, l’odio e la collera
- Il torpore e l’indolenza
- L’agitazione e l’ansia
- I dubbi scettici
Questi cinque elementi ostacolano lo sviluppo mentale e, quindi, la nostra consapevolezza.
I Sette fattori dell’illuminazione:
- La consapevolezza delle proprie azioni, dei propri movimenti, fisici e mentali;
- Lo studio della dottrina, che include il riflettere, il conversare e confrontarsi su temi religiosi, etici, filosofici, l’assistere a lezioni su tali temi;
- L’energia, cioè l’impegno nel conseguire i propri scopi;
- La gioia, che è il modo con cui eseguiamo i nostri scopi (opposto al pessimismo, alla tristezza e alla melanconia);
- Il rilassamento di corpo e mente;
- La concentrazione;
- L’equanimità, cioè l’affrontare ogni accadimento esistenziale con la mente calma, tranquilla, priva di turbamenti.
I Quattro (stati) Incommensurabili (dell’esistenza):
- “Metta”, l’ amore e la benevolenza universale e illimitata verso tutti gli esseri viventi (come una madre ama il proprio figlio);
- “Karuna”, la compassione per chi soffre, per chi è in difficoltà o in afflizione;
- “Mudità”, la gioia compartecipe per il benessere e la felicità altrui;
- “Upekka”, l’equanimità.
LA RETTA CONCENTRAZIONE, quella delraccoglimento che conduce allo stato di trance, del quale riconosciamo 4 stadi:
- Primo stadio, abbandono dei pensieri malsani (concupiscenza, malizia), dei desideri passionali, del torpore, dell’ansia, dell’agitazione e del dubbio; rimangono le attività mentali della gioia e della felicità;
- Secondo stadio, nello stato di gioia e felicità, si abbandonano tutte le attività mentali, concentrando la mente su un “punto”;
- Terzo stadio, sparisce la gioia, rimane la disposizione alla felicità e all’equanimità;
- Quarto stadio, sparisce tutto, rimane l’equanimità e la consapevolezza.
Così la mente disciplinata è quella educata dal retto sforzo, dalla retta consapevolezza e dalla retta concentrazione.
La saggezza è la qualità dell’esistenza che si poggia sui due piani del retto pensiero e della retta visione.
IL RETTO PENSIERO, è quello non interessato, distaccato da desideri e scopi egoistici. Il retto pensiero è quello d’amore e di non-violenza.
Distacco disinteressato, amore e non violenza sono i cardini della saggezza.
In tutte le sfere della vita (individuale, sociale, politica, ecc.), i pensieri e le azioni di desiderio egoistico, di malizia, di odio, di violenza, dipendono dalla mancanza di saggezza.
LA RETTA VISIONE, è la comprensione delle cose come sono, come sono espresse dalle 4 Nobili verità. Comprenderle vuol dire avere una retta visione.
Buddha distingue due livelli di comprensione.
Il primo, insufficiente, è quello della “conoscenza conseguente”, ciò che noi definiamo “capire”, è la cognizione delle cose sulla base degli elementi intellettivi cui riusciamo ad accedere.
Il secondo è quello della comprensione profonda, penetrare nelle cose e vederne la loro natura, senza denominazioni ed etichette.
È questa una sorta di “comprensione ultima”, possibile solo a una mente sviluppata e liberata da ogni impurità, grazie alla pratica della meditazione.
L’ottuplice sentiero è una proposta di esistenza possibile per tutti e da tutti praticabile; non deriva da alcun impianto di tipo religioso-fideistico e non consiste in cerimonie o rituali; non ha a che fare con alcuna idea di preghiera, né, tanto meno, con alcuna forma di adorazione di un qualche Dio.
L’ottuplice sentiero non contiene quindi, né si collega o rimanda ad alcun significato religioso, nei termini comunemente intesi.
Il Buddha non ha mai parlato dell’esistenza di un Dio o di poteri e forze esterne, sovrannaturali, preesistenti e indipendenti dall’uomo; considerava tutte le realizzazioni umane come frutto dell’attivazione delle facoltà umane; in primis l’intelligenza e la sensibilità.
Da quanto finora presentato appare evidente quanto la filosofia buddista si presenti come più che appropriata base culturale del Counseling e delle filosofie cui lo stesso si appoggia (Esistenzialismo e Fenomenologia), così come si evidenzia quanto sia possibile considerarla fonte di ispirazione fondamentale della Psicologia Umanistica, innanzitutto per quel suo considerare quanto e come l’uomo sia padrone di se stesso.
Ricordiamoci che per il Buddha non esiste altra entità superiore all’uomo, che ne possa decidere il destino.
Il Buddha ha prima scoperto, in proprio, e poi mostrato il sentiero che porta alla Liberazione, al Nirvana.
Il sentiero non gli è stato “rivelato” da alcun messaggero di Dio.
Buddha ci mostra il sentiero che conduce alla Liberazione, ma chiarisce che, per chi vuole raggiungerla, è indispensabile percorrere, in proprio, quel sentiero.
Il buddismo si differenzia dalle visioni, spirituali-religiose, che propongono l’esistenza di un’anima, come entità spirituale in vario modo collegata-integrata all’esistenza delle singole persone, ed in vario modo dalle stesse distinguibile, preesistente ed eterna; così come si differenzia dalle visioni di quel mondo psicologico che postula l’idea di un “Sé” come entità strutturante ogni persona, eppure in qualche modo dalla stessa “a sé stante”, in quanto istanza che ciascuno è chiamato a riconoscere/individuare, affermare e realizzare.
Per il Buddha tali idee sono false, frutto dell’ignoranza e della paura; producono l’attaccamento a pensieri nocivi riguardanti i concetti di “io” e “mio”; sono alla base di ogni desiderio egoistico e di ogni cattivo sentimento (odio, avarizia, vanità, orgoglio, malizia, ecc.); sono fonte di tutti i tormenti del mondo (dai conflitti interpersonali alle guerre tra le nazioni).
Il Buddha propone un insegnamento controcorrente (quindi di difficile affermazione) rispetto alle idee più profondamente radicate nell’uomo, quelle di stampo religioso e metafisico; famose sono le sue parole: “gli uomini, sopraffatti dalle passioni ed immersi nell’oscurità, non possono vedere questa verità, che è sublime, profonda, sottile, ma difficile da comprendere, perché é controcorrente”.
LA DOTTRINA DEL “NON SÉ” (anattà) si collega allo stato delle cose rappresentate dai 5 aggregati e dalla Genesi condizionata.
“Ciò che noi chiamiamo un essere o un individuo si compone di Cinque aggregati, dietro ai quali non esiste nulla che possa essere considerato un io, un atman, un sé o una qualunque sostanza immutabile e impermanente… la dottrina della Genesi condizionata espone un mondo in cui niente è assoluto; ogni cosa è condizionata, relativa e interdipendente; questa è la teoria buddista della relatività”. (Walpola Rahula. op. cit. pag. 87).
LA GENESI CONDIZIONATA.
Un “valore” fondamentale del buddismo è l’aver compreso che il rapporto tra gli accadimenti della vita non è solo quello, diretto, di “causa-effetto”.
Le cose non accadono necessariamente come effetto particolare di una qualche causa specifica.
Le cose si presentano in maniera correlata, quando ce n’é una ce n’é un’altra, quando non c’è l’una non c’è l’altra.
Le cose si condizionano reciprocamente e sono interdipendenti, senza essere necessariamente l’una la causa diretta dell’altra.
La genesi condizionata è un insegnamento buddista che si fonda su 4 correlazioni fondamentali:
- “quando c’è questo, c’è quello”
- “apparendo questo, appare quello”
- “quando non c’è questo, non c’è quello”
- “cessando questo, cessa quello”
Di queste quattro correlazioni, la dottrina della genesi condizionata presenta un’articolazione di dodici casi, dove quando c’é un fattore c’é l’altro, quando appare uno, appare l’altro, quando non c’è l’uno, non c’è l’altro, cessando l’uno, cessa l’altro:
- L’ignoranza condiziona le azioni volontarie (o formazioni karmiche)
- Le azioni volontarie (alias formazioni karmiche) condizionano la coscienza
- La coscienza condiziona i fenomeni mentali e fisici
- I fenomeni mentali e fisici condizionano le sei facoltà umane (i 5 sensi + la mente)
- Le sei facoltà umane condizionano il contatto sensoriale e mentale
- Il contatto sensoriale e mentale condiziona le sensazioni
- Le sensazioni condizionano il desiderio/sete
- Il desiderio/sete condiziona l’attaccamento
- L’attaccamento condiziona il divenire / ri-esistere
- Il divenire / ri-esistere condiziona la nascita
- La nascita condiziona l’esistenza / dukkha
- L’esistenza condiziona la vecchiaia e la morte (la vecchia intesa come declino delle facoltà umane e la morte intesa come lo scomparire di ciò che esiste alla percezione del mondo) e condiziona l’ignoranza.
Questi 12 fattori sono ciò che mantengono in essere la genesi condizionata del ciclo dell’esistenza umana.
Ciascun fattore è sia condizionato, sia condizionante e può essere visto come l’anello di una catena chiusa a collana, senza soluzione di continuità, così che ogni movimento/accadimento in ciascun anello si ripercuote in tutti gli altri.
Se ciascun fattore ne condiziona direttamente un altro e, indirettamente, tutti gli altri, alla cessazione di uno corrisponderà la cessazione di tutti gli altri e, quindi, la cessazione del processo ciclico dell’esistere e della rinascita.
Per il buddismo non esiste una “causa prima”, tutto è interconnesso; la totalità dell’esistenza è relativa, condizionata e interdipendente; lo è quindi anche la volontà degli individui e ogni loro genere di attività mentale.
Comprendere questo stato delle cose, la dottrina del “non sé”, dell’impermanenza e di ogni insegnamento buddista non è possibile per il solo tramite delle attività mentali del pensare, immaginare, riflettere, analizzare, ragionare, ecc. ecc.
Buddha ci dice che ci sono due tipi di verità: quella “convenzionale” e quella “ultima”.
La verità convenzionale è quella cui accediamo per il tramite di denominazioni convenzionali come “Io”, “Tu”, “Essere”, “Individuo”, “Ego”, “Sé”.
Le denominazioni convenzionali sono utili a un livello di comprensione delle cose che è quello che potremmo denominare del “capirle”.
Capire le cose ci permette di “usarle” socialmente e per noi stessi; è ciò di cui la nostra ignoranza ci permette di farci un’idea, che ci permette di accettarle e di comunicarle.
La verità ultima è ciò che possiamo comprendere facendone esperienza diretta percorrendo l’ottuplice sentiero, cioè praticando le attività che questo propone; così possiamo arrivare alla comprensione profonda delle cose dell’esistenza, facendone esperienza diretta.
Comprendere la verità ultima è ciò che possiamo chiamare Nirvana ed è come conquistare il paradiso.
La conquista del “Paradiso” non può avvenire come premio per aver eseguito prescrizioni divine.
“L’emancipazione dell’uomo dipende dalla sua conquista della Verità, non dalla grazia benevola di un dio, né da un potere esterno, che ricompensa i comportamenti buoni e giusti (corretti e benevoli)”.
Per il Buddha l’emancipazione dell’uomo dipende dalla sua capacità di arrivare alla verità, non dalla volontà di una qualche “Grazia divina”.
Per questa ragione Buddha invitava alla libertà di pensiero, non dettando alcun codice ai suoi monaci; a chi gli chiedeva quale insegnamento seguire, era solito rispondere:
“… Quando capite da soli che certe cose non sono salutari, ma cattive e sbagliate, allora abbandonatele ….
Quando capite, da soli, che certe cose sono salutari e buone, allora accettatele e seguitele”.
Il Buddha insegna a diffidare di chi si proclama portatore di verità ed esorta a verificare personalmente ogni insegnamento, da chiunque arrivi (anche da lui stesso).
Per chi cerca la verità, non conta da dove arrivi (l’origine di una scoperta è materia per gli accademici).
Ciò che conta è vederla/comprenderla, superando così ogni ragionevole, legittimo, dubbio.
Per procedere sul sentiero della verità è indispensabile avere dubbi, ma è necessario saperli superare.
Ovvero il dubbio è necessario, ma risolverlo è indispensabile, per arrivare alla verità.
Per questo servono libertà di pensiero e tolleranza, due capisaldi fondamentali del buddhismo e del Counseling!
Per il Buddha non è proprio di un uomo saggio sostenere: “Questa sola è la verità, tutto il resto è falso”.
È questa una forma di attaccamento, contraria alla natura impermanente delle cose.
Un uomo può avere una sua fede, ma non scambiarla con la verità.
Un uomo che dice “questa è la mia fede”, dice il vero. Se dice “questa sola è la verità”, dice il falso; perché non ha potuto conoscere e sperimentare, personalmente, che “solo la sua fede dice la verità e tutto il resto è falso”.
Etichettare le cose le rende fisse, le trasforma in pregiudizio, impedendo di coglierne la mutevolezza e l’impermanenza.
Le religioni sono basate sulla fede. Nel Buddhismo ciò che conta è il vedere, conoscere, comprendere (come nel Counseling!).
Abbiamo bisogno di credere se vogliamo accettare una verità che non può essere vista e compresa personalmente; non ne abbiamo bisogno per ciò che riusciamo a vedere e a comprendere.
L’insegnamento del Buddha è qualificato come ehi-passika = venite a vedere, non venite a credere.
Nei testi buddhisti, le espressioni per riferirsi a chi ha realizzato la verità presentano il vedere come possibilità derivante dalla conoscenza e dalla saggezza, non dalla fede.
Per comprendere la verità del “non sé”, Buddha esortava a non sostenere alcuna opinione o punto di vista, ma di vedere le cose oggettivamente, come sono, senza proiezioni mentali (stesso sforzo praticato nel counseling e stessa valorizzazione dell’ “ovvio”).
Per questo esortava a vedere il “sé”, l’ “io”, l’ “essere” per quello che sono: una combinazione cangiante di aggregati fisici e mentali che agiscono insieme in modo interdipendente, in un flusso di continui cambiamenti soggetti alle leggi di causa-effetto, in un’esistenza dove non può esistere, quindi, alcun “essere” permanente ed immutabile (concetto ripreso dalla Psicoterapia della Gestalt, per la quale il “sé” è una combinazione mutevole di elementi, perché è funzione del divenire di ciò che accade sul confine di contatto tra individuo e ambiente; prima della Psicoterapia della Gestalt, ci aveva pensato l’esistenzialismo filosofico a rilanciare l’insegnamento del Buddha, considerando l’ “Essere” una funzione variabile del tempo e delle circostanze).
La dottrina della “Genesi condizionata” ci aiuta a capire quella del “non sé (anattà)”.
La questione che, del buddismo, il counseling ripropone è:
- cosa possiamo farcene di ciò che capiamo e come?
Del buddismo, noi counselor facciamo nostro l’interesse per ciò che è utile e accogliamo l’invito a lasciare andare ogni forma di speculazione mentale e metafisica.
Come il Buddha, ci chiediamo e chiediamo: “questo a cosa, mi / ti, serve?”
Non siamo interessati alla verità assoluta (da buoni “fenomenologi”!)
Ci interessa il benessere; ci interessa la felicità!
Buddha era un maestro pragmatico, insegnava solo ciò che portava alla pace e alla felicità.
Col suo insegnamento Buddha indicava all’uomo come raggiungere la sicurezza, la pace, la tranquillità, la felicità, il nirvana, ma si “accontentava” di aiutare gli altri a vivere una vita migliore.
Il suo insegnamento è basato sull’amore, sulla compassione e sul servizio degli altri.
Nei suoi discorsi, Buddha si dedica alle questioni di vita ordinaria delle persone comuni, proponendo precetti pratici di gestione della stessa, con particolare riferimento alle relazioni familiari, alle questioni sociali e di politica governativa.
Famosi i cinque precetti per il laico buddista:
- Non distruggere la vita
- Non rubare
- Non commettere adulterio
- Non mentire
- Non assumere sostanze inebrianti
Buddha aveva a cuore il benessere materiale delle persone, perché lo considerava indispensabile sostegno per le pratiche proposte con i suoi insegnamenti.
Considerava il benessere economico indispensabile per la felicità umana; incoraggiava il miglioramento delle condizioni materiali, ma non riconosceva nessun tipo di progresso che non avesse un fondamento etico e spirituale, causa prima e ultima di una società felice, pacifica e soddisfatta.
Il messaggio di Buddha è di non violenza e pace, amore e compassione, tolleranza e comprensione, verità e saggezza, rispetto e riguardo per ogni forma di vita, libertà dall’egoismo e dall’odio.
Buddha insegnava che l’odio non è mai placato dall’odio, ma dalla gentilezza.
La gentilezza vince la collera, la bontà vince la malvagità, la carità vince l’egoismo, la verità vince la menzogna.
Non ci può essere pace, né felicità, per chi vuole soggiogare il prossimo.
La sola conquista che porta pace e felicità è la conquista di se stessi.

IL CUORE BUDDISTA DEL COUNSELING.
Dopo avere presentato, per sommi capi, il Buddismo, vediamo adesso in che modo il Counseling vi si collega e da questo trae aiuto.
Il primo e più immediato aiuto, che il buddismo offre al counseling, é l’insegnamento in materia di sofferenza.
Se c’è una condizione che accomuna chi si rivolge al counseling, questa è la sofferenza.
Piccola o grande che sia, la sofferenza è una condizione vissuta da tutti i clienti che si rivolgono a un counselor.
Chi si avvicina al counseling è mosso dal bisogno di meglio affrontare una qualche questione esistenziale che lo sta mettendo in difficoltà, cosa che è sempre accompagnata da una qualche forma di sofferenza, piccola o grande.
Un conflitto interpersonale, un esame che non si riesce a superare, una scelta difficile da prendere, la perdita di una persona cara, una pena d’amore, una crisi professionale/occupazionale, una malattia, producono, immancabilmente, sofferenza e portano da noi counselor i nostri clienti.
Rifiutare questa sofferenza, non volerla, è, invariabilmente, quanto fanno tutti i nostri clienti.
Certo, a chi piace star male?
È naturale rifuggire il malessere e voler star bene!
Tutti i clienti che, come counselor, ho avuto presentavano una stessa condizione: soffrivano per quello che stava loro capitando e non lo volevano.
La sofferenza, però, era quanto di più naturale e sano stesse loro capitando, date le situazioni nelle quali si dibattevano.
Per chi stia subendo una qualsiasi problematica esistenziale, soffrire è assolutamente naturale e sano; testimonia uno stato di buona vitalità, che risponde coerentemente a quanto sta accadendo; preoccupante sarebbe l’indifferenza, il non sentirsi male, che molto probabilmente segnalerebbe disfunzioni psichiche di chissà quale tenore.
Cosa vuole chi si rivolge al counseling?
Vuole smettere di stare male; vuole risolvere i propri problemi e stare bene!
Cosa accade facendo counseling?
Accade di imparare che stare male è un accadimento assolutamente naturale e, per di più, benefico, perché ci spinge a cercarvi rimedio, intervenendo sulle sue cause.
Facendoci aiutare da un counselor, impariamo che non voler stare male, quando si declina in rifiuto “tout court” della nostra sofferenza, ci impedisce di farvi i conti, ci impedisce di accoglierla e di accettarla, che è la “conditio sine qua non” per superarla.
In altre parole, un counselor ci aiuta ad accettare la sofferenza, ponendo così le basi indispensabili per superarla.
Quando, come ci ha insegnato il Buddha, riconosciamo che il nostro soffrire è cosa assolutamente naturale e ineludibile, quando accettiamo la sofferenza come contingenza legata a situazioni contingenti, che, debitamente gestite, potranno essere attraversate e superate, creiamo una nostra forte base psicologica, che ci sostiene, attiva e stimola a mettere in atto quanto necessario per uscire dalla nostra sofferenza e lasciarcela alle spalle.
Rifiutare, invece, la sofferenza è una forma di afflizione che la fortifica (come insegna il Buddha!).
Con le sue quattro nobili verità, il Buddha ci dice che nella vita c’è la sofferenza, che la sua origine è il non volerla; ci dice che tutto è impermanente, che la sofferenza cessa e ci indica il sentiero per superarla.
Di questo sentiero il counseling fa propri gli insegnamenti fondamentali, applicandoli nelle proprie scuole e nelle proprie relazioni professionali:
- L’ascolto, innanzitutto, come pratica di ascolto propriocettivo, che è la base della meditazione vipassana, che, a sua volta, è la base della meditazione buddista.
- L’accoglienza di quanto si ascolta, in primis della sofferenza.
- La fiducia nel processo dialogico relazionale del counseling, che ripropone simbolicamente il naturale fluire delle cose e degli accadimenti della nostra esistenza e la loro impermanenza.
- La valorizzazione del “qui e ora”.
- La non violenza e la gentilezza, di pensieri, parole e opere, come leva di benessere e di felicità.
- L’attenzione e la concentrazione come stati meditativi volti alla comprensione delle cose.
- La consapevolezza e i modi per raggiungerla (respiro, attenzione e concentrazione).
- L’osservazione non giudicante.
- Il riconoscimento della natura olistica della vita e lo studio delle questioni etiche, spirituali e politico-sociali, che la intessono.
- La considerazione degli elementi condizionanti l’esistenza degli individui, che tanto ricorda la dottrina della “genesi condizionata”!
Fare counseling è uno stare nella cornice delle 4 nobili verità del Buddha ed è un ritrovarsi a muoversi fra gli otto piani del suo ottuplice sentiero:
- Retta visione
- Retto pensiero
- Retta parola
- Retta azione
- Retta sussistenza
- Retto sforzo
- Retta consapevolezza
- Retta concentrazione
Fare counseling è ritrovarsi a fare la spola tra questi 8 piani, aiutando i nostri clienti a fare altrettanto; facciamo counseling ispirati dai principi culturali, etici e morali, propri delle quattro nobili verità e dell’ottuplice sentiero, e facciamo counseling declinando nelle nostre sessioni di counseling (nelle forme possibili in quella contingenza) le più importanti pratiche mentali e comportamentali proposte dal Buddha: ascolto, accoglienza, gentilezza, osservazione non giudicante, attenzione al respiro, retta visione, retto pensiero, retta parola, retta azione, retta consapevolezza, retta concentrazione.
Buddha abbandonò una vita mondana di agi, benessere e prosperità materiale, per cercare una via d’uscita dalla sofferenza universale.
Noi counselor, più modestamente, ci muoviamo per promuovere il benessere, nostro e dei nostri clienti; questa nostra intenzione e i modi per tradurla in pratica trovano nella filosofia e nell’insegnamento buddista un humus culturale, valoriale e didattico di straordinaria importanza.
Potremmo dire che il counseling è una delle varie declinazioni moderne-contemporanee del buddismo.
Chiunque, nel mondo occidentale, da fine ottocento in poi (siano questi filosofi, psico-analisti, terapeuti, psicologi, counselor o trainer di qualsivoglia disciplina mentale/comportamentale), abbia agito e/o agisca professionalmente una qualche forma di relazione d’aiuto, è debitore dell’insegnamento buddista.
In particolar modo questo vale per i cultori della “mindfulness”, che hanno spudoratamente vestito il buddismo con i nostri panni occidentali, come esemplifica la seguente definizione (tratta da Selene Calloni Williams, Silvia C. Turrin, “Mindfulness Immaginale”, Edizioni Mediterranee):
<<Si può dire che la Mindfulness è la meditazione applicata alle neuroscienze e alla psicologia, con l’intento di sanare stati psicofisici – quali ansia, angoscia, tristezza…
Mindfulness è un termine inglese, che significa “pienezza mentale” o anche “presenza mentale”. Amplia la capacità di sviluppare una comprensione trasformativa dell’esperienza e, al contempo, plasma una mente dinamica, aumentando la creatività. Questo processo di ri-attivazione e risveglio mentale é possibile, poiché la meditazione agisce sulle sinapsi cerebrali e sulla produzione di endorfine, acuendo intuizioni e felicità …
Praticando la meditazione si mette in moto una sorta di riavvio del cervello: si sviluppano maggiore attenzione, lucidità, chiarezza e presenza mentale. Questo “riavvio” aiuta a sciogliere schemi mentali rigidi, cristallizzati nel tempo, sostituendoli con modelli più flessibili, ricettivi e potenti >>.
Il nostro fare counseling attiva le stesse dinamiche mosse dalle pratiche di meditazione (che in vario modo sono riproposte nelle sessioni di counseling) e, per i nostri clienti, ne condivide gli esiti: “maggiore attenzione, lucidità, chiarezza e presenza mentale”.
Come nella meditazione, il nostro fare counseling attiva, nei nostri clienti, processi di consapevolezza che ne sciolgono gli schemi mentali/comportamentali rigidi e sclerotizzati, sostituendoli con forme flessibili, più capaci di farli star bene.
Della “via della meditazione” proposta dal Buddha, noi counselor mutuiamo lo spirito.
Da bravi counselor, quando facciamo counseling, ciascuno di noi, prima d’essere un io che pensa, attivando le funzioni logiche tipiche della mente (analizzare, giudicare, immaginare, dedurre, associare, interpretare), è un io che si concentra nella pratica della nuda attenzione, dell’osservazione non giudicante e dell’ascolto.
Immergendoci in tali pratiche, eludiamo le funzioni logiche tipiche della mente e ci apriamo all’intuizione, quel formarsi analogico di pensieri non costruiti coscientemente e volontariamente; non pensati, quindi, intenzionalmente da un “io” logico-pensante, pensieri che si affacciano alla mente spinti dall’intuizione (come venissero da chissà dove e da chissà chi! Come ci dice il Buddha: “ci sono pensieri, non c’è chi pensa”).
Quanto più ci si addentra nella pratica della nuda attenzione, dell’osservazione non giudicante, dell’ascolto, tanto più possiamo arrivare a perdere i confini dell’ “io” (come idea di noi stessi) e del sé (come unità psico-fisica limitata, di emozioni-sentimenti-corpo-spirito).
In una condizione di meditazione profonda, questo può portare a sconfinare in quello stato di “sentimento oceanico”, raccontato da chi ha vissuto l’esperienza mistica del senso di partecipazione unitaria, infinita e indefinibile, con il divino e con l’universo.
Nella dimensione relazionale in cui si muove il nostro fare counseling, le nostre pratiche di ascolto, di nuda attenzione e osservazione non giudicante ci portano, più “semplicemente”, a riconoscere e a cogliere gli elementi di unificazione esperienziale che stiamo vivendo con il nostro cliente, e lui con noi; il condividere (per il tramite dei nostri feedback) tali elementi con i nostri clienti, e su questi confrontarli, è un dare un là all’attivazione e allo sviluppo dei loro processi di consapevolezza, dai quali trarranno quanto serve per migliorare i loro modi di stare con, e di affrontare, le difficoltà che stanno vivendo.
Insomma, potremmo chiamare “Buddhacounseling” il nostro fare counseling!
Cosa accomuna, quindi, buddismo e counseling?
Partendo dal riconoscimento del fatto che il benessere delle persone, che è lo scopo del counseling, per il Buddha era condizione indispensabile per raggiungere l’illuminazione, arriviamo a riconoscere che l’aspetto che più di tutti accomuna counseling e buddismo è il focus sul “lavoro di consapevolezza”.
In questo manuale, pensiamo alla consapevolezza come “quello stato personale di coscienza e di conoscenza in grado di contenere, e agire al meglio, il contatto con quanto, di funzionale alla soddisfazione dei nostri bisogni, si muove fuori e dentro di noi”.
La consapevolezza cui aspira il Buddha è uno stato personale raggiungibile dedicandosi a un insieme di pratiche dalle quali il counseling, come percorso formativo e come relazione professionale d’aiuto, trae grandi ispirazioni e insegnamenti.
Il concetto di “Yogging”, le esercitazioni di consapevolezza funzionali all’apprendimento del saper fare counseling, le pratiche di base del counseling, presentate in questo manuale, sono tutta materia che parte dagli insegnamenti buddisti e arriva alle Scuole di Formazione IN Counseling, passando attraverso una cultura umanistica fatta di studi storico-sociali, antropologici, sociologici e letterari, che incontrano le teorie della Gestalt e le relative declinazioni filosofiche e psicologiche, ritrovandosi infine a rispolverare e rielaborare, del buddismo, principi e pratiche meditative.
Vediamo, allora, che i principali insegnamenti buddisti si declinano nel nostro fare counseling, poggiandosi sull’ascolto e sulle pratiche di respiro/attenzione/concentrazione, su quelle dell’accoglienza, dell’osservazione non giudicante e della comunicazione non violenta.
Il counseling è una relazione che si muove sui tre piani:
- del Racconto
- della Rivisitazione
- dell’Apprendimento
Il primo piano, quello del racconto, riguarda ciò che il cliente racconta (appunto!) circa cosa lo sta mettendo in difficoltà e i modi attraverso cui gli corrisponde.
Il secondo piano, quello della rivisitazione, riguarda le nuove esperienze che, rispetto a quanto ci ha raccontato, il cliente vive nella relazione di counseling e, in forza di questo, fuori dalla stessa.
Il terzo piano, quello dell’apprendimento, concerne tutto ciò che il cliente impara grazie alle esperienze vissute nella relazione di counseling e in quelle verso cui la stessa lo orienta.
IL RACCONTO
Uno dei principi fondamentali della meditazione buddista è il portare al momento presente, al “qui e ora”, tutti i pensieri che affollano la mente e le sensazioni a questi collegate.
Nel nostro fare counseling, farci raccontare dal cliente cosa gli è accaduto, come vi ha corrisposto e cosa se n’è fatto, è prassi ordinaria volta a riportare e a far emergere e riconoscere, nel “qui e ora” della sessione di counseling, i contenuti e le forme di quell’esperienza, per vedere e analizzare quanto è ancora lì, a condizionare l’esistenza del nostro cliente.
Noi counselor chiediamo al cliente di raccontarci ciò che gli è accaduto, mettendoci in ascolto e chiedendo al cliente di fare altrettanto (dopo avergli spiegato cosa questo significhi).
Uno degli scopi della meditazione buddista è quello di rendersi coscienti di quanto ci sta accadendo e di come vi corrispondiamo.
Chiedendo al nostro cliente di raccontarci le sue cose, stando in ascolto, puntiamo, sostanzialmente allo stesso risultato: renderlo e renderci coscienti di quanto gli è accaduto, di come vi ha corrisposto e di cosa e come questo è ancora presente e agisce in lui.
Il nostro accogliere il suo racconto, stando in ascolto, serve a noi counselor per empatizzare col cliente, per percepire la quantità e la qualità migliore degli elementi (di sentimento, senso e azione) che hanno caratterizzano i suoi vissuti, ed ancora sono presenti, e raccogliere, così, il materiale di consapevolezza da restituirgli, offrendogli i nostri feedback e confrontandolo, nel corso del processo dialogico relazionale che portiamo avanti con lui.
Tutto questo avviene nel tempo presente della sessione di counseling che stiamo svolgendo; tutti gli effetti di sentimento e senso che riusciamo a riconoscere sono fissati nel “qui e ora” del loro accadere, anche grazie ad un nostro continuo richiamarlo, con domande tipo:
- Ora come ti senti?
- Ora che ne pensi?
- Ora cosa faresti?
Questi racconti fanno riemergere sentimenti, pensieri e quant’altro vissuto nei momenti cui gli stessi si riferiscono, ma ancora attivi e presenti.
Quello che conta per noi è che, a livello di sentimento e di senso, ciò che il racconto del nostro cliente propone è quanto chiede di essere cambiato e che, per essere cambiato, necessita d’essere riconosciuto e affrontato, in quanto presente ed attivo nel “qui e ora” del nostro fare counseling.
Il “qui e ora” della relazione di counseling è il tempo presente in cui quel cambiamento può avvenire; esattamente come avviene nel “qui e ora” della meditazione; è lì che si impara a stare con ciò che si incontra, si diventa capaci di affrontarlo, producendone i necessari cambiamenti.
Il tutto avviene, nella meditazione buddista come nel counseling, grazie alle pratiche di nuda attenzione, di osservazione non giudicante, di piena accettazione di ciò che, stando in ascolto, si riesce a sentire e a percepire.
LA RIVISITAZIONE
Parliamo di rivisitazione perché, insieme al cliente, ripercorriamo con l’immaginazione e con varie tecniche di riproposizione espressiva – simbolica quanto il cliente ha già raccontato; lo facciamo per fargliene fare nuova esperienza, facendogli rivivere il tutto non solo nei propri panni, anche in quelli degli altri, che nel suo racconto hanno avuto parte.
Attraverso questa rivisitazione, il cliente vivrà esperienze nuove; nuove nelle forme, nuove nei contenuti d’emozione, di senso e di sentimento; tutte novità dalle quali prenderanno le mosse i suoi nuovi progetti sul cosa fare e come per migliorare quanto gli è accaduto e, soprattutto, il suo modo di corrispondergli.
Le forme di rivisitazione cui qui ci riferiamo poggiano tutte sulle pratiche che il nostro fare counseling (ascolto, accoglienza, osservazione non giudicante, attenzione al respiro, concentrazione, gentilezza, compassione) assorbe dagli insegnamenti del Buddha; il tutto assume forza maggiore per il suo avvenire all’interno di una relazione interpersonale (quella di counseling), vera e reale.
Questo rende vivida l’esperienza del cliente, facendola diventare una vera e propria esperienza di crescita personale, per i contenuti di apprendimento che contiene.
L’APPRENDIMENTO
Ogni sessione di counseling è un’ora in cui, confezioniamo per i nostri clienti le esperienze dalle quali loro stessi apprenderanno quanto a loro serve per risolvere le questioni nelle quali si stanno dibattendo.
Lo facciamo ascoltando i racconti dei nostri clienti, facendoglieli rivisitare, richiamandoli all’ascolto e, facendogliene fare pratica (di ascolto), richiamandoli ad accogliere ciò che sentono, aiutandoli a valorizzarlo,
Si potrebbe dire che noi counselor, in un nostro modo originale, dalla chiara valenza pedagogica (vedi cap. 5.2, “La funzione pedagogica del counseling”, in questo stesso manuale), aderiamo al richiamo del Buddha “venite a vedere”, che tanto sta a dire: “fatene esperienza e sceglietelo, quando vi sarà sembrato buono e giusto”.
Le pratiche di stampo meditativo, che il counseling ricalca dagli insegnamenti del Buddha e propone nelle proprie sessioni di lavoro, sono ciò che permettono la formazione e la definizione, per i nostri clienti, dell’esperienza di quanto loro accade in ogni sessione di counseling.
Il fatto che in quei “qui e ora” accadano cose vere, che coinvolgono clienti e counselor in relazioni interpersonali vere e partecipate, sostenute da un contatto interpersonale vero, un vero e proprio contatto di consapevolezza, è quanto permette la costruzione di vere e proprie esperienze che, a buon titolo, possiamo chiamare di crescita personale; perché da queste i nostri clienti imparano cosa e come fare per superare le difficoltà esistenziali che stanno vivendo.
Come già scritto in questo manuale, nel capitolo 5.2, “La funzione pedagogica del counseling”, “Imparare vuol dire apprendere qualcosa di nuovo e farlo proprio, qualcosa di cui prima non si sospettava l’esistenza, qualcosa di utile e funzionale ad un qualche miglioramento esistenziale”.
Questo è l’apprendimento che matura chi fa esperienza del nostro saper fare counseling, un sapere di cui vediamo le radici nella cultura che il Buddha ha saputo originare e della quale noi counselor siamo tanto debitori.
Buddismo e counseling fanno leva sulla ricerca della consapevolezza.
La consapevolezza è uno stato della mente e del corpo, che comprende la coscienza e la conoscenza di quanto sta avvenendo, dentro e fuori di noi, che, in qualche modo, ci riguardi.
A trovarla (la consapevolezza!) si ottiene, sempre, uno stato d’animo più tranquillo e fiducioso, se non proprio di completa pace interiore; quello stato d’animo tanto voluto sia da chi pratica gli insegnamenti buddisti, sia da chi si rivolge ad un counselor, per riceverne l’aiuto.
Lo sviluppo dei nostri stati di consapevolezza migliora il nostro contatto con la vita, rendendoci:
- più generosi, al di là di ciò che possediamo,
- più spinti dal cuore, nei nostri pensieri e comportamenti, quindi più propensi ad agire per finalità benefiche,
- meno spaventati dagli ostacoli che incontriamo, perché meno attaccati ai risultati che possiamo ottenere,
- molto meno propensi a farci prendere dalla rabbia,
- più capaci di apprezzare la vita, per quello che ci offre, invece di lamentarci e/o impanicarci per quello che ci manca e/o siamo chiamati a fare.
Buoni stati di consapevolezza catalizzano energia buona. Buona per soddisfare i nostri bisogni, buona per dedicarci a ciò che amiamo, buona per realizzarlo, buona per stare bene.
Il buddismo può essere visto come uno “stile di vita”, centrato sull’amore compassionevole per ogni forma di vita e di esistenza.
Il buddismo ha chiaro quanto l’amore e la compassione siano sentimenti indispensabili per “godere” a pieno delle gioie della vita e accettarne, con pazienza e grazia, i dolori.
Saper accettare con pazienza e grazia i dolori della vita e saperne godere a pieno le gioie è una “competenza” personale che rende soddisfacente e luminoso il vivere di tutti i giorni.
All’acquisizione di tale “competenza” volgono le pratiche buddiste; verso l’acquisizione di tale competenza muove la Formazione IN Counseling e il fare esperienza della relazione di counseling.
“Competenza” è la capacità di agire e di muoversi in modo funzionalmente adeguato, nei contesti e nelle situazioni in cui questo è indispensabile, per stare meglio e/o per conseguire gli scopi voluti.
La vita ci chiede di essere vissuta con competenza, per beneficiare di quanto ci offre.
Insomma, bisogna saper vivere!
Il buddismo è un “sapere” della vita, da cui chi fa counseling è ispirato; cosa evidente sia nella riproposizione delle pratiche “meditative” di ascolto, osservazione non giudicante, compassione, gentilezza, sia nella valorizzazione degli insegnamenti dell’ottuplice sentiero (retta visione, retto pensiero, retta parola, retta azione, retta sussistenza, retto sforzo, retta consapevolezza, retta concentrazione).
Sul desiderio, proprio della nostra natura umana, di migliorarci, di accrescere le nostre conoscenze, di esplorare mondi sconosciuti, fanno leva il buddismo e il counseling; questa “leva” è l’attenzione e la concentrazione sul “sentire” dei nostri sensi, sul libero vedere della nostra mente, che ci porta a riconoscere l’interconnessione di tutto ciò che vive e a muoverci ecologicamente (con rispetto e amorevolezza) nelle nostre vite e nei mondi in cui queste viviamo, prendendoci cura di noi e degli altri, producendo così il nostro e l’altrui benessere.
Questo perché, come dice Stefano Bettera (op. cit.), vedere in modo chiaro ciò che ci fa bene e fa bene fare ci fa decidere di metterlo in atto, ci fa fare “la cosa giusta”, perché farlo ci fa stare bene, connette positivamente il dentro che c’è in noi con quello che c’è fuori.
Con le pratiche di meditazione buddista impariamo a vedere con chiarezza la differenza che c’è tra il reagire compulsivo, nevroticamente automatico, fatto di gesti e comportamenti fissi, abitudinari, e, al contrario, il rispondere in modo funzionalmente adeguato a quanto la situazione richiede; che è, poi, quanto impara chi si rivolge al counseling!
Per noi counselor, il lavoro con i nostri clienti è di accompagnarli a vedere in modo chiaro le proprie reazioni nevrotiche e la ripetizione automatica dei propri comportamenti, aiutarli a trovarne di nuovi, di volta in volta adeguati alle circostanze in essere.
Possiamo fare questo perché su questo è centrata la nostra Formazione IN Counseling, sullo sviluppo di un’attitudine e di una sensibilità relativa al “prendersi cura” del proprio stato di consapevolezza e farlo, principalmente, attraverso la valorizzazione della propria presenza, del proprio esser-ci, in contatto e in relazione, momento dopo momento, con noi stessi e con tutto ciò che ci circonda.
Esattamente come il Buddha invitava a fare, noi counselor non scegliamo mai, né chiediamo di farlo, in modo dogmatico o secondo principi assoluti, astratti. Teniamo conto della situazione in corso, con i nostri clienti; teniamo conto dei loro vissuti e delle loro condizioni reali, non di condizioni idealmente, teoricamente, possibili; ecco perché (come faceva il Buddha) la nostra attenzione contempla sempre il corpo, il nostro e quello dei nostri clienti, nella sua unicità e irripetibilità, per quello che, nei singoli momenti in cui facciamo counseling, è in grado di farci sentire, di dirci e farci vedere.
C’è molto caro l’insegnamento del Buddha sull’inesistenza di risposte buone per ogni situazione, per ogni persona.
Cos’è “buono” per i nostri clienti lo percepiamo grazie alla libertà dai pregiudizi, dalle idee fisse e dalle convinzioni, che impediscono di “sentire” l’altro (nel senso di empatizzare con quanto l’altro sta vivendo-provando).
Con il nostro ascoltare rendiamo l’altro parte del nostro stesso vissuto e ne possiamo testimoniare i contenuti (con i nostri feedback), aiutandolo così a riconoscerli.
In altre parole, possiamo testimoniare l’esperienza dell’altro, comprendendone le identità e condividendole compassionevolmente, come richiede il Buddha.
L’ascolto nel counseling, come nella meditazione vipassana/buddista, è “propriocettivo”; ascoltiamo cioè le nostre percezioni sensoriali, le nostre sensazioni, la nostra carne e quello che vi accade; lo ascoltiamo come un’eco di quello che il nostro cliente ci racconta e offre di se stesso.
Questo nostro ascoltare lo condividiamo, facendolo diventare un atto relazionale, che contatta l’esperienza altrui e ne favorisce l’intelligibilità.
Così rilanciamo l’esperienza buddista dell’ascolto come primo atto di cura, che parte come attenzione rivolta a se stessi e si sviluppa in riconoscimento dell’altro, nella relazione con l’altro, consapevoli che l’altro sente quello che sentiamo noi:
“Se l’atto del prendersi cura inizia e si genera dall’attenzione rivolta verso se stessi e la propria condizione, contemporaneamente questo stesso atto si completa e può esplicarsi solo se inserito nel contesto della relazione” (Stefano Bettera, op. cit.)
Il counseling, come il buddismo, non è interessato ai “perché” degli accadimenti; Buddha si chiedeva “come fare” a fronteggiare agli accadimenti, positivamente.
È questo uno straordinario insegnamento che noi counselor accogliamo e poniamo a fondamento del nostro pensare e agire (a differenza degli psicologi, che sono sempre alla ricerca delle cause e dei perché alla base dei disturbi mentali/comportamentali dei loro assistiti).
L’attenzione al “come fare” implica la fiducia nel naturale, positivo, fluire processuale degli accadimenti che ci riguardano.
Se è buono come facciamo le cose, sarà buono il conseguente, processualmente collegato, fluire delle cose che ci riguardano; così la pensava il Buddha, così la pensiamo noi counselor, fino a farne principio strutturante delle nostre relazioni di counseling, che, anche per questa ragione, conduciamo in chiave diaologico-processuale.
“Al Buddha poco interessa spiegare il perché dei fenomeni, ma comprendere piuttosto le conseguenze dei fenomeni stessi e la capacità trasformativa che contengono, se visti come occasione di pratica e di risveglio. In questo sistema il ruolo centrale spetta al processo, che è libero, non scontato, aperto e per questo conserva un profondo potenziale di guarigione individuale e sociale” (S. Bettera, op. cit.).
Il Buddha, avendo sperimentato personalmente quali condotte (retta azione, retta parola, retto pensiero, retta sussistenza, retta visione, retto sforzo, retta concentrazione, retta consapevolezza) favoriscano le pratiche di meditazione (quelle pratiche di meditazione che, quand’anche non dovessero condurci al nirvana, sicuramente migliorano la nostra esistenza), esorta a seguire tali condotte, presentandole e proponendole ripetutamente nei suoi insegnamenti.
Ugualmente facciamo noi counselor, sia nelle nostre formazioni, sia nel nostro fare counseling: siamo esortati ed esortiamo a declinare tali condotte, siamo invitati e invitiamo a stare in ascolto, prestando attenzione alla respirazione, accogliendo ciò che sentiamo, osservandolo senza giudicarlo, facendocene il meglio che possiamo (Ricorrente è il nostro domandare ai nostri clienti: “cosa ti dice ciò che stai sentendo? Cosa te ne puoi fare? “a cosa ti serve fare quello che stai facendo?”, ecc. ecc.), usando parole gentili e accoglienti, pensando positivamente, ricercando visioni più chiare degli accadimenti che ci riguardano .
Il counseling propone, come il buddismo, l’accento sulla responsabilità personale e sull’etica della consapevolezza.
Responsabilità personale come capacità di stare in ascolto e accogliere ciò che si sente; la responsabilità di osservare sospendendo il giudizio, di accettare le conseguenze delle proprie azioni, di produrre più funzionali sforzi per esplorare, sperimentandole simbolicamente, nuove possibilità di pensiero, azione e sentimento.
È questa un’attenzione al fare che esorcizza il sentimento che più influenza la nostra mente e i nostri comportamenti, ostacolandone gli opportuni cambiamenti: la paura.
Anche questo è uno degli insegnamenti fondamentali del Buddha.
Di questo insegnamento noi counselor facciamo tesoro, aiutando i nostri clienti a fare i conti con le loro paure.
Lo facciamo con la partecipazione attiva nelle nostre relazioni di counseling, coinvolgendoci emotivamente, stando nei processi di sentimento-pensiero-azione che lo stare in relazione sviluppa.
Partecipiamo palesando la nostra intera umanità, donandola ai nostri clienti con il nostro stare con loro e con le nostre condivisioni (i nostri feedback), che qualificano le nostre relazioni come un luogo in cui il cliente smette di sentirsi solo e accede così alla forza e al coraggio che gli servono per fare i conti con le proprie paure.
Alcune righe sopra è stato citato il pensare positivamente come una condotta che noi counselor “riprendiamo” dall’insegnamento buddista.
Chiaramente, non ci riferiamo al “pensare positivo” tanto decantato da molti sedicenti guru della crescita personale in salsa americana (tipo quella del “nothing is impossibile”).
Ci riferiamo alla valenza causativa del pensiero, alla quale il Buddha tanto richiama, invitando ad azioni e comportamenti in grado di condizionare positivamente il nostro pensare, ad esempio l’uso di parole e forme di comunicazione gentili e accoglienti, che fluiscono spontaneamente quando proviamo gratitudine, gioia ed entusiasmo; sentimenti che a loro volta si affacciano al nostro cuore se ci fermiamo ad ascoltarlo.
Il Buddha richiama il valore trasformativo delle parole, quando sanno trasmettere significati e muovere sensi in grado di orientare i pensieri delle persone e muoverne i comportamenti.
Un bravo counselor conosce il potere trasformativo delle parole, e delle forme della comunicazione, e lo usa conseguentemente, aderendo anche per questa via allo spirito buddista.
Le parole danno forma alla nostra coscienza e costruiscono le nostre conoscenze.
Le parole sono un mezzo importantissimo di trasmissione e valorizzazione delle nostre esperienze.
Le parole sono un creato capace di creare esperienze nuove.
Le parole servono a incontrarsi e a dividersi.
Le parole assumono potenza quando sono usate per esprimere pensieri guidati dai nostri sentimenti più nobili: compassione, amore, gioia, entusiasmo.
Per questo il Buddha era solito dire che <<l’uomo saggio usa la parola “sentire”, cioè “provare”, “percepire”, per indicare la propria esperienza umana; un’esperienza cioè vissuta, incarnata, sentita attraverso i sensi.
Per questo nel buddismo il corpo diventa il tramite per entrare in contatto con la dimensione più profonda dell’essere vivi.
Per questo il continuo richiamo al respiro, alla condizionalità, alle sensazioni del corpo stesso>> (Stefano Bettera, op. cit.).
Chi sa di counseling non può non riconoscere l’identità di visione che il counseling propone del buddismo!!!
SE SEI INTERESSATO AL COUNSELING, SE VUOI FARE LA FORMAZIONE IN COUNSELING E DIVENTARE UN COUNSELOR:






 Voglio aprire questo blog di “In Counseling”, Scuola di Formazione Professionale per aspiranti Counselor, Innanzitutto, presentandone lo “spirito”. Questo blog vuole essere, in uno spazio virtuale, un luogo reale di incontro e di confronto per tutti coloro che vedono nel Counseling (e/o possono imparare a vedere nel Counseling) uno modo di stare al mondo in grado di migliorare se stessi...
Voglio aprire questo blog di “In Counseling”, Scuola di Formazione Professionale per aspiranti Counselor, Innanzitutto, presentandone lo “spirito”. Questo blog vuole essere, in uno spazio virtuale, un luogo reale di incontro e di confronto per tutti coloro che vedono nel Counseling (e/o possono imparare a vedere nel Counseling) uno modo di stare al mondo in grado di migliorare se stessi... Lo Specchio Magico è una metafora. Lo Specchio Magico è il nome che abbiamo voluto dare alla nostra Associazione. Un’associazione costituita per organizzare, promuovere e gestire progetti di formazione rivolti alla crescita e allo sviluppo consapevole delle persone. Lo Specchio Magico è la metafora del nostro modo di intendere e di fare formazione. Formazione come quel maturare di esperienze con le quali diventare sempre più capaci di soddisfare i nostri bisogni.
Lo Specchio Magico è una metafora. Lo Specchio Magico è il nome che abbiamo voluto dare alla nostra Associazione. Un’associazione costituita per organizzare, promuovere e gestire progetti di formazione rivolti alla crescita e allo sviluppo consapevole delle persone. Lo Specchio Magico è la metafora del nostro modo di intendere e di fare formazione. Formazione come quel maturare di esperienze con le quali diventare sempre più capaci di soddisfare i nostri bisogni.
Grazie Domenico di questo bel capitolo. Sei riuscito a sintetizzare e schematizzare in maniera semplice un argomento tutt’altro che semplice, evidenziando ancora una volta come il sapere necessario per la professione di counselor attinga dalle più svariate fonti. Il tuo manuale potrebbe anche essere intitolato l’arte di vivere in pace con se stessi e con gli altri, ma non renderebbe giustizia al tentativo di dare una dignità propria ad una professione considerata terra di conquista da altre professioni. Questo capitolo, forse più di altri, evidenzia come il counseling necessiti di un sapere che non può essere appreso solo teoricamente … per fare il counselor occorre confrontarsi con i moti del cuore, occorre lottare deponendo le armi, occorre conquistare lasciando andare… il tuo manuale fa vedere queste cose avvisando però che non è sufficiente leggerlo e non basta studiarlo, bisogna fare pratica, sperimentare in prima persona! Come lo è, per il buddismo, la meditazione. Seguendo gli insegnamenti, auspico che il tuo manuale possa essere fonte di ispirazione e di benessere per tutti coloro che vorranno vivere in pace con se stessi e con il mondo!
Grazie Paolo, per queste tue parole e per l’amicizia fraterna che mi dedichi.
Domenico.